













CRASH #2 - MY BODY IS NOT NOBODY, 2022
Galleria Francesco Pantaleone, Milano
a cura di Irene Biolchini
CRASH potrebbe sembrare un lavoro sulla pandemia, sulla costrizione domestica, sulla prigionia e la paura. Invece Loredana Longo aveva iniziato a concepire questa serie molto prima del lockdown e di tutto quello che ne è poi seguito in questi ultimi due anni. Risulta chiaro nei lavori in mostra che l’oppressione non è determinata dagli eventi o dalla limitazione alla mobilità. La libertà non si raggiunge uscendo di casa o distruggendo quello che ci blocca fisicamente nel movimento. La barriera, o il guardrail, non è un limite esterno. In questo senso la mostra CRASH segna un passaggio rispetto alla produzione precedente dell’artista in cui gli ostacoli da abbattere erano il muro (come in PIEDEDIPORCO, 2017), il mobilio borghese (come nella serie EXPLOSION iniziata nel 2006), le pareti della prigione (NOTHING AS IT SEEMS, 2009). In CRASH Loredana Longo sembra chiederci: quale è il confine, il limite, la gabbia? La risposta è solo una: il corpo.
Il corpo è il solo strumento di presa sul reale, il luogo attorno il quale misurare le cicatrici dell’esperienza. La pelle è guscio, involucro e contenitore: l’artista ne sonda i confini e le estensioni, immaginando un corpo-macchina sottoposto a una continua pulsione verso l’autodistruzione, la sfida, il superamento di ogni barriera. Come se solo attraverso il dolore potessimo sentirci vivi. Vi è in questo il ricordo dell’omonimo Crash di Ballard in cui si legge: «Per lui, ferite del genere erano le chiavi di una nuova sessualità, generata da una perversa tecnologia; e le loro immagini stavano appese nella sua galleria mentale come oggetti esposti in un museo da macello[1]». La cicatrice è il segno indelebile dello scontro e del dolore, ma non apre ad una nuova consapevolezza, o come dice l’artista: «L’esperienza non serve, sappiamo bene quali sono le cose che ci fanno male e le rifacciamo. Perché in fondo ci piace quell’errore, l’errore è la vita stessa».
La vita passa attraverso il corpo, attraverso i suoi segni. All’interno di una lunga storia che la precede, Loredana Longo si sofferma sul corpo per misurare una dimensione politica e privata. C’è sicuramente in lei la forza della body art e della performance delle grandi artiste degli anni Sessanta e Settanta: non si può guardare il video ARMOUR senza pensare al corpo impresso nella terra di Ana Mendieta, ma bisogna riconoscere che l’equilibrio panico tra uomo e natura viene qui brutalmente interrotto in favore di una rappresentazione meccanica. Un loop video in cui la liberazione dal guscio si associa all’opera scultorea stesa a terra: ciò che rimane al suolo non è il calco del corpo, il colore rosa riveste il negativo, la pelle rimane all’interno dell’armatura appoggiata al suolo. ARMOUR è quindi una protezione, ma è anche una corazza-guscio in ceramica, un materiale che nella sua fragilità denuncia l’impossibilità alla difesa. Per questo la corazza è il simbolo di un’opposizione, il guscio all’interno del quale si gioca lo scontro. Del resto se pensiamo alla storica donna in armatura, Giovanna d’Arco, possiamo comprendere la forza di ARMOUR. Il lungo processo a Giovanna d’Arco si conclude con un’abiura della donna che, davanti alla pira accesa, firma confermando la propria eresia, le visioni demoniache e giura di non indossare mai più abiti da uomo nella futura vita in carcere. E sarà proprio la negazione di questa promessa, quando all’interno della propria cella Giovanna indosserà nuovamente gli abiti maschili, che l’Inquisizione potrà riunirsi nuovamente, determinare la “ricaduta” di Giovanna d’Arco e condannarla a morte. Nel guscio-armatura di Loredana Longo risiede questa lunga tradizione di violenza sul corpo della donna, sul sistema normativo che da sempre impone cosa una donna debba e possa essere, sul sistema patriarcale che da sempre impone uno sguardo, una visione. Le convenzioni che l’artista faceva esplodere in EXPLOSION, nella serie CRASH vengono portate all’interno dell’armatura, la abitano. La prigione allora non è più una limitazione esterna, ma vive all’interno di noi stessi, ridotti a corpi-macchina, obbligati ad eseguire meccanicamente le convenzioni che ci vengono imposte. Lo scontro non è con il mondo esterno, ma con l’insieme di nevrosi, paure, limiti che ci poniamo quotidianamente. Anche per questo motivo non si esce dalla gabbia, come in CRASHING THE BOX, un video (e una scultura) in cui la lotta contro il guard-rail non determina alcuna uscita. Del resto è l’artista stessa a descrivere la sua ricerca in questi termini: «CRASH diventa lo spazio dell’indescrivibile emozione che si prova quando si è costretti da qualcosa in qualcosa o da qualcuno in qualcosa e infine non si cerca più nemmeno la via d’uscita, come se il fine fosse proprio ferirsi per sentire, poi tutto il resto gli va dietro, è un’atmosfera gelida che descrive spazi soli».
Il punto di congiunzione tra la produzione precedente dell’artista e questo nuovo ciclo di lavori è sicuramente CAPITONNÈ SKIN WALL, una parete di cinque metri in pelle imbottita, ricucita in modo da riportare per sempre l’urto del corpo che lo ha colpito. Anche in questo caso un video accompagna l’opera, permettendo allo spettatore di assistere alla performance in cui Loredana Longo, tutta dipinta di nero, si lancia contro la parete, lasciando così l’impronta del proprio corpo. Saranno poi gli artigiani a seguire quella traccia, a cucire sulla pelle animale il segno lasciato dalla sua.
In ALL MY SKIN il parallelo animale-artista si ripropone: l’opera presenta le esatte dimensioni della pelle di Loredana Longo, ma è aperta e sezionata come nei tagli di macelleria. Su questa pelle si inseriscono le suture a punto metallico: il corpo esposto qui non cicatrizza e continua a mostrare la memoria dell’intervento. Quello davanti a noi è il corpo unico dell’artista, ma un corpo abitato dalle paure, dalle costrizioni e dalle ansie che ci popolano continuamente. In questo senso il suo corpo non è diverso da quello degli altri, pur rimanendo unico. Unico è il guscio che però racchiude le nevrosi che ci uniscono. Nasce così il sottotitolo della mostra MY BODY IS NOT NOBODY, una specie di mantra che ritorna in una serie di lavori esposti nelle due sedi (una scritta neon, una grande pelle, un cassone in metallo) e che si appoggia su un nuovo linguaggio, una sospensione delle regole grammaticali inglesi che dona vita ad una frase solo apparentemente incoerente. Qualcosa che l’artista descrive in questi termini: «MY BODY IS NOT NOBODY per me non significa nulla, o forse tutto, è una filastrocca, una ripetizione. Tutta la mostra indaga il senso del ripetersi degli errori e delle piccole azioni che ci rendono unici (uguali e diversi da tutti)». Ecco dunque che la frase della Longo non significa qualcosa, ma del resto come insegnava Lacan «il linguaggio prima di significare qualcosa, significa per qualcuno».
Loredana Longo ci porta all’interno del suo linguaggio e nel farlo non rispetta grammatiche di nessun tipo, nemmeno quelle delle tecniche adottate: brucia lane e velluti per creare opere in tessuto, dà fuoco alla ceramica prima di cuocerla, distrugge dettagliatissimi setting con esplosioni. Anche in questa nuova serie di opere l’artista ribalta il senso dell’aspettato: esponendo la parte interna di un’armatura, distruggendo gli specchietti retrovisori per cancellare ogni possibile visione retrospettiva. Del resto non c’è passato e non c’è futuro nella coazione a ripetere, non c’è uscita da questo continuo scontro con noi stessi. L’impronta del corpo rimane per sempre registrata nel sedile di SITTING CRASH, ulteriormente bloccato contro la parete da un guardrail.
Ciò che Loredana Longo eredita dalle ricerche degli anni Settanta è l’idea di un campo espanso della scultura, la possibilità di modellare le coscienze degli spettatori e attivare un processo scultoreo. Camminando all’interno della galleria di Milano siamo anche noi dentro alla gabbia-guardrail (grazie alla serie di stampe GUARDRAIL CRASH che ricoprono interamente le pareti), guardando il video ARMOUR avvertiamo anche noi la costrizione, fermandoci davanti alla brillantezza del cassone neon MY BODY IS NOT NOBODY sentiamo di avere un corpo unico e per questo, la nostra unicità ci lega a quella di tutti. Il dolore dello scontro è privato, ma avviene all’interno di ciascuno di noi, quindi ci investe tutti.
Irene Biolchini
[1] James G.Ballard, Crash, Traduzione di Gianni Pilone Colombo, coll. Mistral, Rizzoli, 2000, p. 10.
[2] J. Lacan, Aldilà del principio di realtà, in J. Lacan, Scritti, Vol. 1, a cura di G. B. Conti, Einaudi, Torino, [1974], 2000, p. 77.








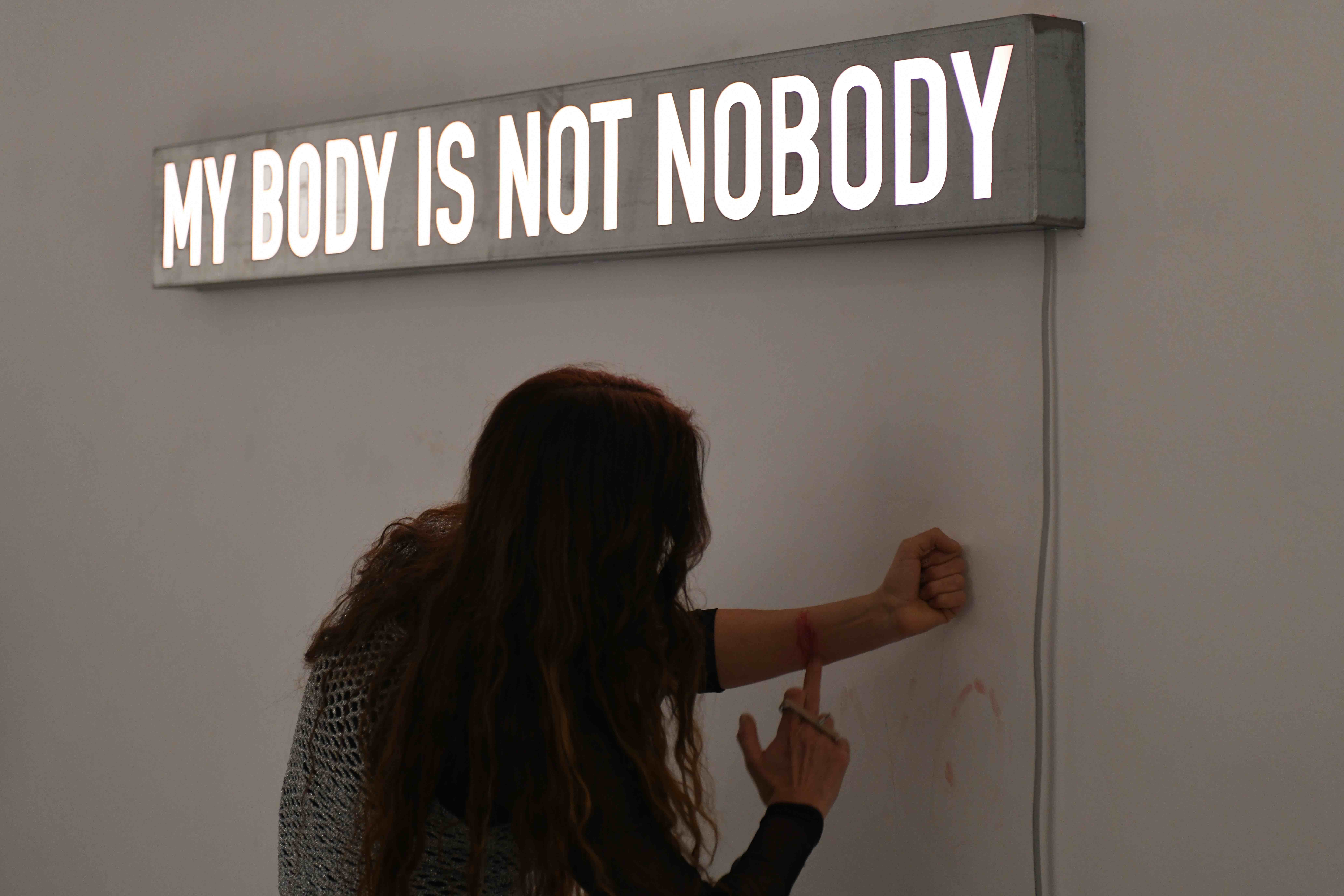





Durante la Milano Art Weekend l’artista ha presentato un’azione inedita dove, ancora una volta, ha detto “NO” all’idea di un corpo-oggetto.
Loredana Longo esce dagli uffici della Galleria Pantaleone, sguardo scuro, impeccabilmente vestita “rock”. Cammina rasentando il muro e subito si intuisce che, alla mano destra, porta uno dei gioielli creati da lei stessi: anelli o tirapugni decorati con schegge di vetro e altri oggetti contundenti. Stavolta l’artista indossa, tra l’indice e l’anulare, un triplo anello dal quale spunta una vite acuminata con la quale – e con la forza del corpo – i muri vengono incisi, graffiati (scratchati, appunto). Una parete dopo l’altra subisce il trattamento, seguendo movimenti rapidi o più difficoltosi, segnati dalla profondità e dall’attrito tra lo strumento-anello-corpo e l’intonaco.
E alla fine, Loredana Longo arriva sotto la scultura-neon che recita l’errato e allo stesso tempo rafforzato messaggio “MY BODY IS NOT NOBODY”. Tra decine di sguardi increduli, l’artista inizia a graffiarsi il braccio con il suo stesso anello-punta, fino a farsi sanguinare, richiamando Gina Pane, Marina Abramović. E ricordandoci, soprattutto, che l’arte è una disperata richiesta di attenzione e che oggi, nell’epoca in cui il corpo si vuole svuotato dei suoi sensi e significati, a disposizione del potere, è urgente rimarcare un secco “NO”. A costo di scriverlo col sangue, su un muro.